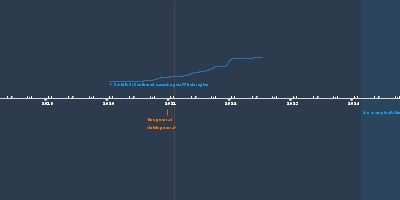Seconda guerra sino-giapponese (7 jul 1937 ano – 2 set 1945 ano)
Descrição:
La seconda guerra sino-giapponese (7 luglio 1937 - 2 settembre 1945) fu il maggiore conflitto mai avvenuto tra la Repubblica di Cina e l'Impero giapponese, e il più grande conflitto asiatico del XX secolo. Combattuta prima e durante la seconda guerra mondiale terminò con la resa incondizionata del Giappone il 2 settembre 1945, che mise fine alla seconda guerra mondiale.Nel complesso la seconda guerra sino-giapponese può essere suddivisa, dal punto di vista strategico, in tre periodi.
+ Prima fase: 7 luglio 1937 (battaglia del Ponte di Marco Polo) - 25 ottobre 1938 (caduta di Hankou). In questo periodo il concetto chiave della difesa cinese è "spazio in cambio di tempo" (以空間換取時間). In pratica l'esercito cinese cercò di rallentare l'avanzata giapponese verso le città industriali del nord-est in modo da permettere di smontare le industrie per ritirarle verso il Chongqing, ove ricostruire una base produttiva.
+ Seconda fase: 25 ottobre 1939 - luglio 1944. In questa lunga fase della guerra la strategia cinese fu quella di colpire l'avversario attraverso azioni improvvise miranti a tagliare le linee di rifornimento giapponesi, bloccando così anche eventuali manovre offensive. Un esempio di questa tattica può essere esemplificata nella difesa di Changsha, attaccata numerose volte senza successo.
+ Terza fase: luglio 1944 - 15 agosto 1945. Questo periodo corrisponde a quello del contrattacco generale mirante alla completa liberazione del territorio cinese.
Dal 1937 al 1941 la Cina combatté da sola, mentre dopo l'attacco di Pearl Harbor a fianco dei cinesi si schierarono anche le forze alleate, sia statunitensi sia sovietiche, che fornirono materiali, uomini e servizi addestrativi alle forze comandate da Chiang Kai-shek. Dopo la resa del Giappone, nazionalisti e comunisti cinesi tornarono a scontrarsi per il controllo del Paese, avviando così l'ultima fase della guerra civile.
All'inizio del conflitto ciascuna divisione giapponese era considerabile pari, come potenza di fuoco, a quattro divisioni cinesi.
Il Giappone non aveva le forze, e neppure l'intenzione, di occupare e gestire tutta la Cina e in effetti, nella fase della loro massima espansione, i territori occupati consistettero nel nord (Manciuria e regione di Pechino), nelle regioni e città costiere e nella valle dello Yangtze, per il resto il proposito era la creazione di una serie di stati fantoccio filogiapponesi. A causa dell'atteggiamento di superiorità tenuto dai nipponici e delle atrocità (massacri di civili, campi di concentramento, utilizzo della popolazione come "cavia" per esperimenti medici, lavoro forzato) commesse dall'esercito, l'amministrazione giapponese fu estremamente impopolare.
La Cina, dal canto suo, era completamente impreparata a una guerra totale, essendo priva di un'industria pesante in grado di supportare lo sforzo bellico e con pochi mezzi corazzati e veicoli per lo spostamento delle truppe. Fino alla metà degli anni trenta la Cina aveva sperato che la Società delle Nazioni fosse in grado, e avesse l'intenzione, di proteggerla dall'espansionismo del Giappone. In aggiunta a tutto ciò il governo nazionalista di Nanchino era maggiormente interessato al confronto interno con il Partito comunista che alla difesa dell'integrità territoriale della Cina.
Subito dopo l'inizio dell'attacco giapponese a Shanghai nel 1937, Chiang Kai-shek comprese che per ottenere lo sperato aiuto degli Stati Uniti e delle altre nazioni la Cina avrebbe dovuto mostrare di possedere almeno una certa capacità di resistenza. Dato che una ritirata troppo rapida dalle zone costiere avrebbe allontanato la possibilità di appoggio estero, Chang decise di tentare la difesa di Shanghai e schierò le sue truppe migliori, le divisioni addestrate, organizzate e armate dagli istruttori tedeschi a difesa dei principali centri industriali.
Dal 1933 anche l'Italia aveva sviluppato una politica di sostegno al regime del Kuomintang, vendendo alcuni dei più moderni apparecchi da caccia (Fiat C.R.42, Breda Ba.27, Savoia-Marchetti S.M.81) e altre forniture militari (quali i tankette CV33). Da notare che lo stesso capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica cinese era un ufficiale italiano, ossia il generale Roberto Lordi. L'Italia aveva offerto essenzialmente del supporto aereo sotto forma di mezzi, istruttori e tecnici e, grazie a una società mista italo-cinese, incominciò a installare una fabbrica aeronautica. Ma dopo l'adesione al Patto Anticomintern l'Italia si avvicinò al Giappone e fu una delle poche nazioni a fornire armi, apparecchi (in particolare i bombardieri Fiat B.R.20 con relativi istruttori) ed equipaggiamento all'esercito giapponese, ma in numero limitato, poiché l'Impero nipponico era ampiamente autosufficiente nella produzione di armi.
Seppur in maniera non ufficiale l'opinione pubblica statunitense, che all'inizio degli anni trenta era stata favorevole al Giappone, cominciò a orientarsi verso il Kuomintang, anche a causa delle notizie sul comportamento dell'esercito giapponese nei confronti dei civili. Nell'estate del 1941 gli Stati Uniti permisero la costituzione di un corpo di piloti volontari, detti poi le Tigri Volanti, dotati di velivoli di fabbricazione statunitense, per potenziare la difesa aerea cinese. In effetti i volontari non entrarono in azione fino a dopo lo scoppio delle ostilità tra Stati Uniti e Giappone. Un'altra azione anti-giapponese fu l'inasprimento dell'embargo sull'acciaio e sul petrolio nei confronti del Giappone, azione questa che convinse l'Impero del sol levante che gli Stati Uniti non avrebbero permesso ulteriori azioni militari nel sud-est asiatico alla ricerca soprattutto di petrolio, il che condusse all'Attacco di Pearl Harbor.
Il governo della Cina Nazionalista, che fino a quel momento aveva evitato di dichiarare apertamente guerra al Giappone per non vedersi chiusi del tutto gli aiuti dagli USA (in base alla politica di neutralità), formalizzò lo stato di guerra a partire dall'8 dicembre, il giorno dopo l'attacco. La prospettiva cambiava completamente e da una strategia di sopravvivenza si passò a una strategia per una vittoria definitiva.
Lo scontro di interessi tra Cina, USA e Regno Unito emerse chiaramente durante la guerra nel Pacifico. Il premier inglese Winston Churchill si dimostrò riluttante a inviare nuove truppe in Indocina nel tentativo di riaprire la strada della Birmania, ossia un corridoio attraverso l'Indocina appunto per far affluire rifornimenti alla Cina i cui porti principali erano tutti in mano giapponese. Oltre alla prevedibile ostilità cinese verso la politica del premier britannico, Europe first, anche le richieste di ulteriore impegno militare cinese nella zona della Birmania vennero viste come un tentativo di usare la potenza cinese per difendere l'impero coloniale inglese nel sud est asiatico e proteggere l'India da un possibile attacco giapponese.
Un ulteriore motivo di attrito tra Cina e Regno Unito fu l'appoggio cinese all'indipendenza dell'India, posizione rimarcata in un incontro tra Chiang Kai-shek e il Mahatma Gandhi nel 1942. L'interesse statunitense per il teatro cinese era principalmente nella consapevolezza dell'alto numero di truppe giapponesi che questo impegnava e dalla possibilità di posizionare in territorio cinese basi aeree. Nel 1944, quando già la situazione del Giappone aveva cominciato a deteriorarsi, il Giappone lanciò una vasta operazione, operazione Ichigo, per attaccare appunto le basi aeree che avevano cominciato a essere operative.
Nell'ultima fase della guerra il Giappone prese in considerazione di ritirare parte delle truppe schierate in Cina per affrontare gli USA, ma l'unico effetto di questo intendimento fu lo spostamento dell'armata del Guandong, operazione che finì per facilitare l'avanzata delle truppe dell'Unione Sovietica dopo la sua entrata in guerra contro il Giappone l'8 agosto 1945. Nel 1945 venne messo a punto un piano congiunto tra Cina e USA per liberare del tutto il territorio occupato dal Giappone, ma l'intervento dell'Unione Sovietica (Operazione tempesta d'Agosto) e la resa del Giappone con la conseguente fine della guerra non permisero di renderlo operativo.
Il 9 agosto del 1945, dopo lo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, l'Unione Sovietica denunciò il suo patto di non aggressione con il Giappone e attaccò i nipponici in Manciuria conseguentemente agli accordi presi a Jalta che prevedevano tale azione entro tre mesi dalla fine della guerra in Europa.
Adicionado na linha do tempo:
Data:
7 jul 1937 ano
2 set 1945 ano
~ 8 years